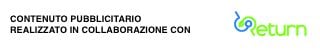Negli ultimi anni, le città di tutto il mondo stanno affrontando un cambiamento sempre più evidente: piogge improvvise che diventano alluvioni, estati roventi, frane e incendi sempre più frequenti. Fenomeni che un tempo sembravano eccezionali oggi fanno parte della normalità e mettono a dura prova territori e comunità. Le cause sono abbastanza note: il clima che cambia, l’espansione urbana disordinata, e l’uso eccessivo del suolo che riduce la capacità della natura di assorbire e regolare l’acqua. Il risultato di tutto ciò è un pianeta più fragile, in cui ogni evento meteorologico estremo rischia di trasformarsi in una catastrofe.
Ma i disastri naturali non sono un destino ineluttabile. Con un po’ di pianificazione, innovazione e rispetto per l’ambiente, infatti, è possibile prevenire e ridurre i danni. In diverse parti del mondo ci sono già diversi esperimenti e progetti pionieristici che stanno dimostrando che un modo più intelligente di convivere con la natura non solo è possibile, ma necessario.
Come prevenire i disastri naturali: i progetti mondiali
Uno degli esempi più interessanti di progetti pensati per prevenire e ridurre i danni arriva dalla Cina, dove esistono le sponge cities, ovvero le “città spugna”. Per contrastare gli allagamenti urbani causati dalle piogge torrenziali, si trasformano interi quartieri con soluzioni verdi: pavimentazioni permeabili, parchi che raccolgono l’acqua piovana, laghetti artificiali e tetti verdi. Così l’acqua viene assorbita e rilasciata lentamente, riducendo il rischio di inondazioni e migliorando allo stesso tempo la qualità della vita urbana.
Nel Regno Unito, a Pickering, nel nord dello Yorkshire, hanno scelto un approccio diverso ma altrettanto innovativo, con il progetto Slowing the Flow. Dopo anni di inondazioni ricorrenti, la comunità ha investito in interventi naturali: migliaia di alberi piantati sulle colline, torbiere ripristinate, piccoli sbarramenti nei torrenti che trattengono l’acqua invece di lasciarla scendere di colpo a valle. Non è stata costruita una grande diga, ma una serie di mini dighe integrate al paesaggio quasi invisibili.
Anche in Myanmar, paese colpito spesso da frane e alluvioni, la prevenzione è diventata sempre più importante, e sono stati sviluppati sistemi di allerta precoce che combinano sensori sul territorio e informazioni raccolte dagli stessi abitanti. In questo modo quando il terreno dà i primi segnali di instabilità, le comunità possono ricevere un avviso tempestivo ed evacuare in tempo. Una tecnologia semplice ed efficace, in grado di salvare vite.
Che rischi corre l’Italia
E in Italia? Purtroppo il nostro Paese conosce bene i rischi legati al dissesto idrogeologico. Frane, alluvioni, erosione costiera: quasi ogni anno assistiamo a tragedie che colpiscono comunità grandi e piccole. I dati dell’ISPRA parlano chiaro: il 94% dei comuni italiani è esposto ad almeno uno di questi rischi. In totale, sono stati censiti oltre 636.000 fenomeni franosi e quasi 6 milioni di persone vivono in aree a rischio. Nel 2024, la superficie nazionale classificata come “pericolosa per frane” è aumentata del 15%, arrivando a oltre 69.000 chilometri quadrati: quasi un quarto dell’intero territorio. Numeri che rendono evidente la fragilità del nostro Paese.
Le cause sono in parte naturali, visto che viviamo in un territorio montuoso, con versanti ripidi e terreni spesso instabili, ma gran parte della responsabilità è nostra: infatti, anche se il cambiamento climatico intensifica l’intensità e la frequenza di forti piogge e di eventi meteorologici estremi, a peggiorare la situazione sono l’urbanizzazione disordinata, il consumo di suolo, la costruzione in aree a rischio e la mancanza di manutenzione del territorio.
Che cos’è il progetto Return
Anche in Italia si stanno sviluppando progetti che affrontano in modo innovativo i rischi naturali e ambientali. Tra questi c’è Return, un’iniziativa finanziata dal Pnrr che punta a rafforzare il monitoraggio, la previsione e la gestione integrata dei rischi su scala locale e nazionale. Questo progetto adotta un “approccio multirischio”, perché non considera solamente i singoli eventi naturali – come alluvioni, frane o terremoti – o quelli antropici – come inquinamento e incidenti industriali – ma anche le loro interazioni e i possibili effetti a cascata come ad esempio frane o tsunami innescati dai terremoti.
Per fare tutto questo, il progetto si serve di un ecosistema digitale che riproduce contesti reali in ambienti virtuali, permettendo di simulare i vari ipotetici scenari e pianificare strategie di mitigazione. In questo ecosistema ci sono due territori virtuali, Returnland e Returnville, che servono a capire meglio quali aree sono più vulnerabili e a testare gli interventi sul territorio. E non solo: questo progetto ci dice che fare prevenzione è possibile: non servono solo muri e barriere, ma collaborazione, scienza e innovazione. Ed è così che l’Italia può diventare un Paese capace di proteggere la propria bellezza.